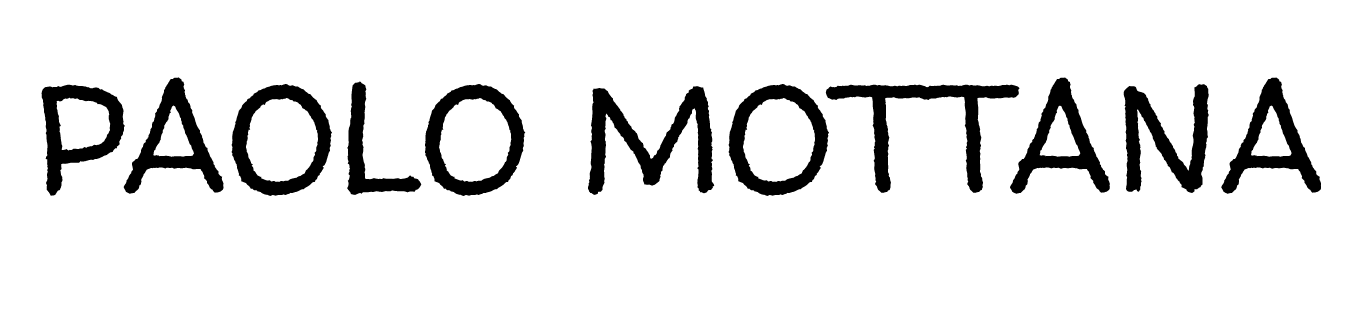Vorrei parlare di un oggetto troppo evidente e forse per questo davvero misterioso. Un oggetto che mi è caro, che nomino, talora forse non sempre con il giusto grado di consapevolezza, o di approfondimento.
Non voglio tirare qui in ballo la lunga lista di tutti quelli che hanno parlato, specie in filosofia, di questo oggetto, l’esperienza. Né men che meno in educazione. E’ fin troppo ovvio che essi parlano in me, come tanti altri e tanto altro.
Questo oggetto mi è caro, l’esperienza, specie se autentica, e già so che aggiungendo questo attributo molti storceranno il naso, in un certo senso perfino io. Ma, proprio con tutto il suo alone ambiguo, il suo odore metafisico e altro, non ne trovo uno migliore. L’esperienza autentica, comunque, fa la differenza. In fondo in tutto.
Che cosa sia un’esperienza, è già difficile dirlo. Ma proverò a far tacere tutte le obiezioni che affiorano ogni volta si provi ad affrontare un’espressione come questa. Di certo è qualcosa che ci riguarda.
Esperienza. Così difficile, così sfuggente. Si è quasi sempre troppo distanti, o distratti, o insensibili, per esperire davvero. Le migliori esperienze ci accadono, inattese : forse proprio per questo, perché non avevamo sondato il terreno, non ci eravamo preparati, non avevamo indossato l’abito adatto, l’espressione adatta, e innescato la paura sottile, o invece spessa, che quell’esperienza categorizzata induce, forse proprio per questo. L’esperienza autentica ci assorbe, ci possiede. E si incarna profondamente in noi.
Oggi, nel tempo in cui la paranoia spadroneggia in ogni dove, e dove occorre essere preparati, istruiti, preventivi, è difficile fare esperienza. Almeno un’esperienza autentica appunto, integra, veemente.
Una esperienza di questo genere, che porta in sé i connotati di quella cosa altresì logora che chiamiamo avventura, è qualcosa che ci coinvolge pienamente. Il più pienamente possibile. Con tutti i sensi anzitutto, al completo. Partecipi e presenti, sensibili e attenti, appassionati e ricettivi. Quanto è difficile, se si pensa a come, nelle nostre vite tutto diventi, giorno dopo giorno, prevedibile, routinario. Come è difficile essere svegli, oppure in uno stato di estatica disponibilità, che non equivale alla presenza della coscienza ma a quella plenaria del corpo, acuta, talora insostenibile, come nel furore di una folla, o nel contatto smisurato di un amplesso.
Ovvio, noi facciamo continuamente esperienza, la nostra esperienza cresce, e forse, man mano che cresce si atrofizza anche, necessariamente, terapeuticamente. Perché l’esperienza, quella autentica, è faticosa, è perfino crudele, a volte.
Un’esperienza autentica però, tale che pervada tutto il nostro organismo, che lo scuota dalle fondamenta, che solleciti e tenda al massimo i nostri nervi, la carne, i sensi, l’attenzione, la curiosità, che lo contorca e rovesci come un quadro di Soutine, resta un oggetto nevralgico per percepire che si sta vivendo e ancor più che si sta incorporando ciò che si vive, lo si sta trasformando nella propria intima fisiologia.
Essere al centro di ciò che accade, essere al completo, essere pienamente. Tutto questo è esperienza autentica, l’unica esperienza che effettivamente lasci una traccia, talora una ferita, talora un segno potente e irrevocabile, talora un ancoraggio inconscio, pronto a riaffiorare involontariamente, magari molto più tardi, per una coincidenza.
Un’esperienza intensa e densa, avrei detto, e direi, forse, pur consapevole che questo tradirebbe una petizione vitalista che tanto sconforta le buone ragioni di una vita misurata e lunga, e vivibile.
Eppure io credo che questo oggetto misterioso e sempre più sconosciuto, dacché tutto congiura a attutirlo, a evacuarlo, a proteggerci dall’impatto con esso – e che tanto più sollecita chi è ancora giovane ma non solo a rincorrerlo nei modi più estremi e talora inappropriati, posto poi che vi sia un’appropriatezza possibile per l’evento di un’esperienza simile- sia il solo in virtù del quale noi possiamo dire di vivere, di vivere veramente. Ed ecco riapparire l’ombra della metafisica. Nel veramente. Ma rinuncio a problematizzarlo. Lo faccia qualcun altro.
Quando si parla di esperienza in educazione – e quanto lo si fa! Quanto la retorica educativa risuona dell’appello all’esperienza, oggi eufemizzato talvolta, erratamente, mescolato con la retorica del fare, o delle pratiche- non si dovrebbe perdere di vista questa destinazione regolativa. Regolativa poiché non si può mai dire quale sia il livello (quantitativo e qualitativo), cui si può spingere il vissuto di un’esperienza. L’esperienza è a molti livelli.
Ma noi dobbiamo, credo, sapere, che solo disponendo il campo dell’evento (educativo) all’irruzione dell’esperienza, possiamo pensare di rendere davvero un dono a chi, volente o nolente, si trova rimesso, tempo e vita, nelle nostre mani inesperte.
Naturalmente l’organizzazione educativa, nelle sue molteplici forme, è quasi sempre insofferente dell’esperienza, e specialmente di quella autentica. Perché essa è di fatto imprevedibile, e selvatica, e pericolosa. Non tanto perché ci si possa fare fisicamente male, il che talora è possibile, ma perché richiede a chi se ne occupa, di affidarsi a un flusso, a qualcosa che lo oltrepassa e che genera effetti che richiedono una continua revisione delle proprie aspettative. Al punto che forse occorre effettuare un’opera preventiva, essa sì, di bonifica di ogni aspettativa. Sapendo che sarà l’esperienza, o l’evento, a generarne in proprio, singolarmente e pluralmente al contempo, ben oltre ogni pretesa, ridicola, di programmazione.
Ora si tratta qui di riflettere su una questione cruciale. E cioè quali sono le condizioni di possibilità perché un’esperienza autentica si dia?
Chiaro che un’esperienza si dà a patto che si lasci avvenire, anzitutto. E però un’esperienza non è solo un accadere nel vuoto, occorre che vi sia un campo. Occorre determinare un campo, che diviene il limite necessario affinché l’esperienza si affacci, prenda forma, evolva.
Dunque la questione cruciale è quella del campo. Si badi bene, non solo un campo operativo, uno spazio, un tempo, un terreno. Ma anche un campo psicologico, emotivo, simbolico.
Occorre coltivare campi di esperienza. Che sono riserve di tempo e spazio liberate da ogni scoria di prevenzione, di pregiudizio, di aspettativa troppo determinati. Il campo è un campo di possibili che si attivano e rendono possibile l’esperienza se il maggior numero possibile delle presupposizioni intorno ad essa sono state elaborate e dissipate.
Se questo campo è abitabile, desiderabile e esplorabile. Se in esso non prende stanza il timore che ciò che accade sia sottoponibile a un giudizio ma sia semmai aperto alla sorpresa dello scoprirne la trama in divenire. Il campo, dove la paura agisce da esclusiva forma istintuale di attenzione, non deve mai essere affidato alle devastanti incursioni della sorveglianza inquisitiva, della valutazione, del giudizio. Tutto questo vanificherebbe (e vanifica, quanto lo fa, nei territori dell’educazione!) la possibilità dell’esperienza.
La paura, beninteso, è un ingrediente dell’esperienza, una paura talora selvaggia, ma non innescata dallo sguardo interessato di un soggetto supposto sapere pronto a intervenire in essa per rettificarla e normarla.
L’oggetto misterioso è qui o forse là, perduto nel tempo, ma ancora potenzialmente sotto gli occhi di tutti. Nella carne di tutti eppure sempre più sepolto e lontano, nostalgico e impossibile. Si impara crescendo che l’esperienza autentica è quella che va progressivamente abbandonata e anestetizzata per sostituirla con le confortanti ripetizioni di un retto agire in conformità delle aspettative sociali. Ma questo non deve ingannarci.
Ci sarà vita (educazione) autentica solo là dove resisterà esperienza autentica, passione feroce, gusto dell’immenso e senza condizioni.