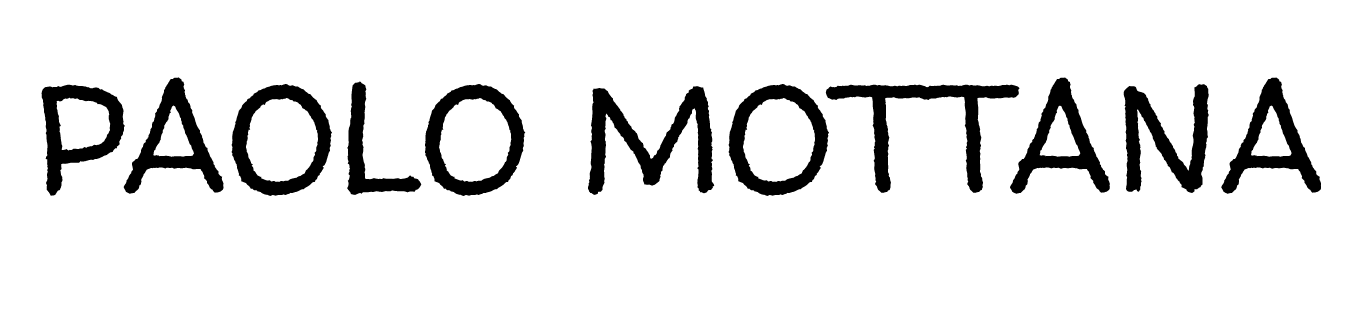In Italia un pensiero radicale ha sempre faticato moltissimo a farsi spazio.
Intendiamoci: radicale nel senso che demistifichi ogni tentativo di manipolare la realtà nei suoi lati contraddittori, drammatici e conflittuali, sostituendovi panacee, ideologia, eufemizzazioni che mirano solo a consolidare lo status quo.
Oggi il pensiero che tenta di mostrare come stanno le cose deve anzitutto fare i conti con il linguaggio stesso, che nel tempo è stato scientemente e in maniera sensibile modificato, sostituendo termini che erano chiari e che consentivano di leggere per esempio il conflitto tra le classi con termini che falsificano, modificano ma soprattutto opacizzano, rendendo tutto molto più sfocato e indecifrabile. A cominciare dalla sostituzione del termine imprenditori a padroni, quello di poveri o “ultimi” a proletari o sfruttati, la messa fuori gioco dell’espressione lotta di classe, per finire con la diffusione del termine capitale esclusivamente in senso positivo (per esempio “capitale umano”, “capitale sociale” ecc.). La penetrazione di questo linguaggio, con tutti i suoi corollari mistificanti direttamente importati dalla fabbrica dell’ideologia, e cioè il mondo anglosassone, ha lentamente ma inesorabilmente intorbidato le acque, e gli interpreti dello sfruttamento si sono ritrovati in bocca parole che non erano più loro ma frutto di un’abile politica di manipolazione del conflitto.
Un ruolo insidioso da sempre lo ha avuto anche l’influsso di ciò che potremmo definire il gergo e la filosofia religiosa (da noi il cattolicesimo) con la sua attenzione verso i poveri e gli ultimi nel senso della cura ma non necessariamente dell’emancipazione. Noi sappiamo bene quanto la religione nel tempo abbia contribuito a indirizzare le buone intenzioni di molti a prendersi cura degli indigenti e al contempo però a mutuare dall’aiuto tributato a loro una remunerazione psicologia significativa (la loro gratitudine rinfranca molto chi è alla ricerca di conferme sul proprio essere dalla parte giusta) lasciando tuttavia in larga misura le cose come stanno.
L’esplosione del fenomeno del volontariato, da sempre un cavallo di battaglia confessionale, è certo uno dei modi con cui si cerca di porre rimedio alle mancanze di un sistema che non cambia strutturalmente e produce continuamente nuove sacche di disagio e di fasce di popolazione abbandonate a sé stesse. Un impegno, quello dei volontari, che offre la sensazione di fare del bene e certo è anche così. Molte persone in condizione di serio disagio beneficiano oggettivamente dell’aiuto di uomini e donne di buona volontà che tuttavia, anche grazie al loro intervento, permettono che certe aree problematiche siano abbandonate appunto alle opere di carità anziché a politiche di cambiamento e di emancipazione. Più in generale, comunque, le opere guidate da questo tipo di motivazione, di cui non si tratta di discutere la serietà individuale, se disgiunte da un’azione di lotta, sembrano più confermare il disagio che condurre alla sua trasformazione.
La posizione di chi sostiene tali pratiche sembra un po’ arrendersi all’idea che sia impossibile porre rimedio diversamente ai problemi degli svantaggiati e che essi siano una dimensione strutturale della vita sociale. Del resto, Gesù era stato chiaro con Giuda (il radicale), quando, alle sue proteste perché la Maddalena usava per ungerlo soldi che potevano essere impiegati per i poveri, rispondeva: “I poveri li avrai sempre con te”. I poveri, i proletari, il sottoproletariato, per questo tipo di visioni del mondo sono una variabile permanente, sono una condizione intrinseca all’esistenza umana il che, dialetticamente, significa, non dimentichiamolo, che lo sono anche i ricchi e i potenti: “Date a Cesare quel che è di Cesare”.
Per le religioni le cose non cambieranno mai. Quello che possiamo fare è salvare la nostra anima e fornire un pizzico di conforto ai diseredati che comunque tali resteranno. O forse diventeranno diseredati con la fede (come si è visto bene in tutte le politiche di evangelizzazione dei popoli su cui non serve neppure insistere essendo evidente a quali condizioni e attraverso quali processi di devastazione abbiano condotto i popoli sottoposti a tali conversioni).
A volte viene da chiedersi se dietro queste convinzioni ci sia una sorta di rassegnato cinismo o solo la consapevolezza peraltro ben evidenziata dai testi fondamentali di queste filosofie, che la vita sulla terra è una penitenza in attesa di tempi migliori.
Vorrei tuttavia provare ad approfondire un poco la questione che soggiace alle motivazioni di coloro che scelgono la via della carità a quella del conflitto. In ballo c’è un concetto molto potente e complesso, quello della salvezza. Cos’è la salvezza per molte fedi? Semplificando un po’ la salvezza è qualcosa che si ottiene (per sé) seguendo appunto un percorso di fede e di misericordia. Significa in larga misura paradossalmente rinunciare a sé stessi per ritrovare sé stessi (ma un altro, quello della salvezza), o ponendo davanti a sé l’altro oppure direttamente affidandosi a Dio (per esempio nelle scelte monacali).
Le strade per arrivarci sono appunto la carità e la preghiera, pratiche che (come vedremo poi anche nel caso della psicologia positiva) garantiscono a chi le segue, di sbarazzarsi del carico del proprio io per gioire dell’aiuto dato agli altri o al servizio di Dio. Beninteso, spesso non si tratta di una finzione (come magari vorrebbe l’ interpretazione psicologica citata sopra che vede nell’aiuto dato agli altri, specie part time, un modo di lavarsi la coscienza) perché la salvezza sta proprio in questo, nell’abbandono di sé (del sé attaccato alle cose mondane ovviamente). Anche in molte iniziazioni esoteriche il fine è questo, nel senso che la salvezza non è necessariamente qualcosa che arriva dopo la morte, al contrario, la si ottiene in questa vita come estasi (uscire da sé) che sia le opere di carità che la preghiera e altri rituali di estinzione del proprio desiderio individuale (per rinascere come “uomini del desiderio” di Dio) realizzano (al tempo stesso però restituendo la sensazione di salvezza personale). Non bisogna essere troppo ingenui nel pensare che chi fa questo lo faccia per ottenere una vita migliore dopo la morte, è qui che si realizza il suo “corpo risorto”, un corpo spirituale che riduce al minimo la sua componente individuale per realizzarsi nella devoluzione di sé all’altro (sacrificio di sé).
E’ un cammino mistico che l’umanità conosce da sempre e che tuttavia si colloca esattamente al polo opposto di quello di chi invece pretende che la propria vita abbia pari dignità rispetto a quella dell’altro e che è nella comune emancipazione da coloro che fissano le condizioni della schiavitù, della mancanza e che sfruttano gli altri che risiede il compiersi di una società giusta, dove l’esistenza piena di ognuno (anche mondana) possa realizzarsi. Una società da cui certo non scompare il male esistenziale ma viene radicalmente ridimensionato quello nelle mani dell’uomo, quello prodotto dalle disuguaglianze economiche, sociali e materiali.
In una situazione, come quella odierna, in cui, a causa della maleficazione pervasiva dei mutamenti radicali, è stata demolita la fiducia nel potere dell’umanità, nelle sue forme collettive, di rivoluzionare le condizioni di vita delle persone, sembra che carità (cura) e preghiera (meditazione) siano le vie d’uscita che assicurano comunque a ciascuno una salvezza personale. E sottolineiamo personale.
A tutto questo, non paghi, quei poteri che hanno largamente in mano le nostre sorti, hanno aggiunto (o meglio hanno approfittato dell’emergere non casuale di) un ulteriore trattamento ideologico pesantissimo, in parte analogo ma più penetrante ancora, che è quello della psicologia positiva.
La psicologia positiva, abbracciata ahinoi a destra e a sinistra, è un veleno dai poteri straordinari. E’ anche difficile controbatterla. Quando uno dei santoni di questa nuova fede vi dice di apprezzare il momento presente, di guardare il bicchiere mezzo pieno, di cercare, in mezzo all’immondizia della vostra vita, di aderire a ciò che in essa si può salvare, fosse anche solo il vostro respiro (e chi può negare che quando si riesce a restringere il proprio campo percettivo al proprio respiro in effetti tutto lo sterco che imbratta la nostra esistenza, almeno per il tempo in cui, a costo certo di esercizi estenuanti, riusciamo a stare abbrancicati ad esso, non si dissolva?), è difficile metterlo in scacco. E poi perché? Lui lo fa con buona intenzione. Come quando Goleman diceva che nel mezzo di una tempesta di ira è cosa raccomandabile ritirarsi e prendersi le pulsazioni alla gola finché non si riducono, come imputargli qualche torto ( a parte la difficoltà intrinseca a ritirarsi da un momento di iracondia per prendersi le pulsazioni…)?
Diciamolo: tutti non possiamo che fruire positivamente delle suggestioni della psicologia positiva quando ci suggerisce di guardare il bene anziché il male, il bello anziché il brutto, il gentile anziché il violento. Certo, si potrebbe imputarle che tende a sopravvalutare la forza della nostra parte consapevole rispetto a quella inconscia e che spesso c’è una tendenza difficilmente domabile in noi a soffrire che ha le sue origini in traumi e vicende che purtroppo si sono fissate nella nostra psiche e che turbano qualsiasi tentativo di tenerne a bada gli effetti (affetti). Ma essi hanno buon gioco a ripeterti che è tutto un problema di focalizzazione cognitiva, di esercizi di spostamento del campo percettivo e soprattutto di concentrazione sul qui ed ora anziché sul là ed allora.
Ma torniamo sull’effetto ideologico di queste psicologie. Il messaggio qual è? Se la realtà è brutta tu hai il potere di spostare la tua attenzione. Se stai male hai il potere di trovare qualcosa che ti faccia star bene, al limite puoi ridurti a una specie di organismo che respira e basta. Cioè il tuo dolore, il tuo dramma, la tua condizione disperata sei tu che li fabbrichi, in realtà non esistono e comunque tu hai il potere di non farli esistere. E quindi, conseguentemente, sei tu il colpevole del tuo star male, nessun altro e solo tu puoi tirartene fuori. Sei tu l’ago della bilancia. Non le condizioni sociali, non la tua condizione di sfruttato, abusato, maltrattato ecc. E guardate che qui la cosa è sottile perché in qualche misura hanno ragione. In effetti anche posto che la colpa sia di qualcun altro, quello che tu puoi fare da solo ora è intervenire su ciò che è nel tuo potere, cioè te stesso. Non lottare con altri per cambiare le tue condizioni sociali, economiche o culturali insieme a quelle degli altri, non punire coloro che ti hanno vessato, non insomma confliggere con chi perpetra violenza e sopraffazione (così non puoi che farti ancora più male ovviamente) ma preoccuparti di te, di come puoi, grazie a mindfulness, yoga e immersione nella natura, ritrovare il tuo buon “funzionamento” (anche se resti uno sfruttato, un maltrattato, un paria).
La psicologia positiva individualizza il problema e incarica ciascuno di noi, individualmente, di venirne fuori. Niente che possa fare più felici i sistemi di potere che mirano a mantenere le cose come sono. Non che non ci sia anche un messaggio buono. In fondo si preoccupano che, in un modo o nell’altro, almeno la nostra percezione della realtà migliori. Sudditi ma felici si potrebbe dire. Lavoratori precari ma felici. Immigrati sui barconi ma felici. Detenuti nei centri di accoglienza ma felici e via dicendo.
Niente di nuovo: stoicismo e atarassia rivisitati.
Per questo nelle scuole entra la mindfulness, o nelle aziende d’avanguardia. Per carità, meglio di un calcio in culo. Si resta nelle medesime strutture, con i medesimi rapporti di potere, vessati strutturalmente ma beneficati soggettivamente. Si viene usati ma rinfrancati. Per quelli fortunati va così. Per gli altri c’è il faidate. Un paio di libri di Eckart Tolle, un po’ di poesia eufemizzante, un po’ di abbraccio delle piante, un po’ di meditazione domestica e il mondo è subito più vivibile. Ed è vero. Provare per credere. Almeno per un po’. Un’ora? Due? Quindici minuti? Beh, perché ironizzare? Quindici minuti di benessere sono meglio di quindici minuti di sofferenza, direbbe l’intelligente emotivo di turno.
Da soli per lo più o in gruppetti di iniziati. Quelli che fanno le pratiche nel week-end (sempre che se le possano permettere perché quelle costano e di solito i più diseredati non se le possono permettere).
Al fondo di tutto questo la dissoluzione lenta ma definitiva delle ragioni del conflitto. Se la colpa è mia perché dovrei ribellarmi, a chi, a me stesso? Basta ribellarsi, facciamo pace. E qui naturalmente interviene, con buona pace appunto delle ragioni giuste o sbagliate, il perdono. Dopo che hai perdonato stai subito meglio, se ci riesci naturalmente. E chi ci riesce dice che è vero, e io gli credo. Se è vero. Spero. Si riesce davvero a perdonare? A chi ti ha fatto del gran male? Probabilmente sì, dopo anni di solito, molti anni, molte sofferenze (determinate da chi ti ha fatto un gran male) e tanto tempo perché di solito è solo il tempo quello che guarisce, lenisce, dissolve.
Certo dopo vent’anni posso perdonare una persona che mi ha portato allora più volte sull’orlo del suicidio. Sono ancora vivo, sono passati vent’anni, sto un po’ meglio. Che mi costa? TI perdono, vai in pace.
Ma attenzione, anche qui, come si è già detto, alla fine colui che è da perdonare non è quello che ti ha fatto del male. Sei tu. Sei tu, come da buona tradizione di psicologia positiva, quello da perdonare. Sei tu quello che si è fatto del male imputandolo all’altro. Alla fine, sei sempre tu, in una sorta di delirio monopsichistico da cui queste filosofie e terapie sono afflitte. Perché sei tu che trascini il tuo fardello invece di sbarazzartene perdonando. E perché in fondo sei tu che non riesci a perdonare a te stesso di aver fatto delle scelte che ti hanno portato al male. Alla fine, insomma la colpa è sempre tua.
Il perdono, la cura, la meditazione, il bicchiere mezzo pieno sono oggi il nostro salvagente. Rallegriamoci.
Al posto della classe, della condivisione tra compagni, dei comitati e delle azioni di lotta, dello spirito rivoluzionario, della partecipazione, delle occupazioni, degli scioperi, della rabbia di chi patisce lo sfruttamento, (non oso dire della rivoluzione è una parola che sono riusciti a rendere indigesta persino a chi ci ha creduto), in mille forme, da parte di pochi, oggi possiamo consolarci, da soli, sul nostro tappetino, intonando mantra, facendoci tutt’uno con il nostro respiro, al minimo funzionamento possibile, qualche volta abbracciando un albero, sempre che ce ne siano nelle vicinanze (non sto a fare la retorica su tutti quelli che vivono in posti dove se gli proponi di abbracciare un albero come minimo ti sputano in un occhio).
Questo è quello che ci hanno fatto e continuano a fare (oltre a tutta la manipolazione al consumo del nulla e al lavoro del nulla che lo sostiene), mescolando le carte, rendendo tutte le vacche nere, confondendoci, impedendoci di pensare, distruggendo i nostri legami più intensi e significativi, facendo poltiglia della nostra intelligenza.
Ovviamente tutto questo avviene per mettere al sicuro i divari di classe, le strutture di potere e fare della grandissima maggioranza dei sudditi una marmellata pronta a bersi qualunque cosa pur di sfuggire alla tristezza spaventosa di un’epoca caratterizzata dal dominio assoluto della merce, del suo spettacolo e della distruzione di tutto ciò che ha ancora un senso al di fuori di essa.
Forse, come già scrivevo venticinque anni fa a proposito dell’intelligenza emotiva, occorrerebbe tenersi la nostra rabbia, la nostra incazzatura, avendo ben chiaro chi sono quelli che manovrano le nostre vite, quali i meccanismi che pongono in atto quotidianamente per svuotarci, ridurci al nulla, strapparci il gusto di vivere pienamente e non ridotti al nostro respiro per abbracciare il cosmo in una sorta di estasi permanente che assomiglia tanto al potere delle droghe, il potere di dimenticarci che pochi, pochissimi si sono presi tutto e agli altri resta la consolazione della cura dell’interiorità (se ne hanno tempo e modo), la mindfulness e qualche altra pratica ascetica che non disturbi nessuno, mi raccomando. E che faccia sentire la vittima soprattutto vittima di sé stessa.
Forse occorre recuperare la nostra rabbia, tenerci strette le nostre emozioni “negative” come le chiamava sempre il guru Goleman, e non permettere che ce le ritorcano contro, che ce le facciano percepire con senso di colpa. Il male (la morte, la malattia, il dolore) è qualcosa che non sconfiggeremo mai, ma il male prodotto dagli uomini, quello intenzionale, quello scatenato dalla crudeltà umana, dal cinismo, dall’indifferenza, dal potere (quale che sia), non lo si sconfigge facendo finta che non esista (come vorrebbero certi presunti saggi: sei tu che dai il potere all’altro di dominarti, e di nuovo la colpa è tua) ma combattendolo e restituendo a noi tutti il diritto di godere dei benefici che il mondo può offrire a ciascuno di noi in modo equo, condiviso, partecipe, a tutte le latitudini.