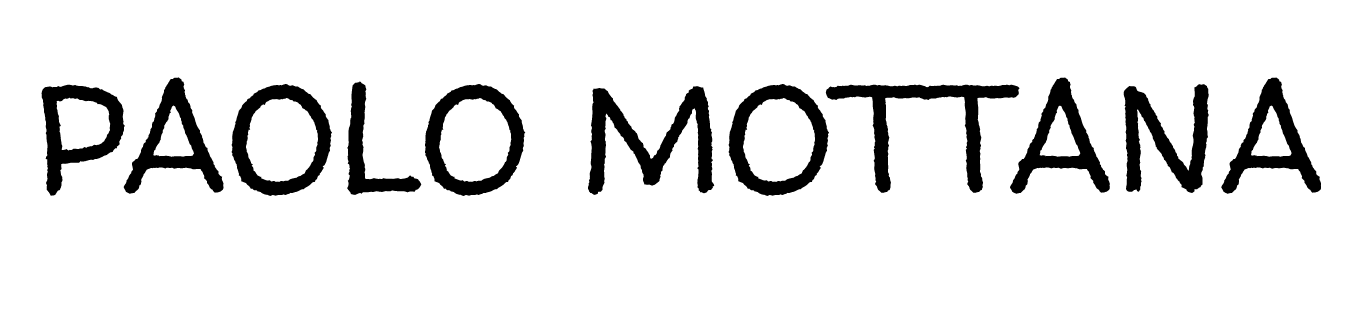Uno dei più potenti tabù dei nostri tempi è certamente quello legato all’ozio. Figlio di una secolare e molto cristiana e poi calvinista ideologia della laboriosità e di un agire che non permetta ai demoni (specie quelli della lussuria) di manifestarsi e prendere possesso del nostro intelletto e soprattutto del nostro corpo, ha trovato il suo coronamento nella morale capitalista. La morale che finalmente ha fatto del lavoro l’unico sistema di valorizzazione dell’individuo e del suo grado di successo in ambito professionale il metro della sua statura umana. Man mano poi che l’accelerazione temporale di cui fin troppi filosofi han già parlato perché sia il caso che io vi insista, la produttività, intesa anche come rapporto tra risultati e tempi e costi, nota a tutti noi come efficienza, è diventato il comandamento supremo del nostro collocarci all’interno del novero dei bravi cittadini.
Ma è fin troppo ovvia la genealogia di tutto ciò. E tuttavia, mentre per lungo tempo, quasi una risacca lunga della morale pagana (per non tirare in ballo gli orientali almeno fino a qualche decennio fa molto più astuti di noi) per la quale era considerato privilegio il non fare, l’astenersi dal fare e far fare agli altri, a sua volta inveratasi nello stile di vita aristocratico, ben scevro di ogni tentazione di farsi insudiciare e stritolare dal travaglio lavorativo, oggi il lavoro come valore (quasi un anagramma) è giunto a insediarsi, direi a sparapanzarsi all’art. 1, dico 1 della nostra Costituzione, la beneamata carta cui tutti indistintamente, tranne i fascisti, continuano a rivolgersi per cercarvi i fondamenti del bene e del male.
Qual terribile svista, quale cecità fallace, collocare lassù, in cima in cima, il valore del lavoro. Il lavoro come fondamento. Le conseguenze sono presto dette: chi non lavora non fa l’amore, come diceva la celebre quanto erronea canzone ma soprattutto chi non è occupato è giocoforza da annoverare tra i marginali, i tristi, i manchi.
Ma non solo inoccupato nel senso di sprovvisto di un’occupazione, più corrivamente anche solo inoccupato nel senso di pigro, restio al fare, ozioso.
Tutti noi, molto spesso prima ancora di essere interrogati sul chi o sul come, veniamo immediatamente sottoposti al test occupazionale: “che fai tu?” o ancor più seccamente “che lavoro fai?”, test che misura il nostro grado di rettitudine sociale, anche nel caso la nostra attività ricada nell’illegalità più o meno scoperta, come nel mestiere di politico, di imprenditore (specie nel ramo edilizio), o di giornalista.
Occhi che si spalancano di fronte alla risposta: “sono disoccupato”, che pone in fuga qualsiasi bella in cerca di ganzo ma anche qualsiasi uomo o donna in carriera nel titanico transatlantico del “prima fai, dopo pensa, eventualmente”.
Una morale ormai così conculcata nell’individuo medio del nostro universo sociale da aver ovviamente invaso anche la vita dei più piccoli. Si intende, in realtà i piccoli sono stati tra i primi ad esserne bersaglio, per i motivi già citati. L’inoperosità, l’appartarsi solitario, la siesta, lo “sdraiarsi” ben maleficato da certi stampaioli correnti, sono diventati da tempo sinonimo di destini catastrofici (leggere bene tra le righe uno dei grandi fautori dell’idiozia contemporanea, Daniel Goleman) o, comunque, un biglietto di sola andata verso il temibile spauracchio delle addiction, specie di quelle più orrende, come l’assumere sostanze che ostacolano il lavoro (non per niente negli ultimi decenni si sono affermate sostanze che non ti lasciano stare ferme neanche le orecchie) o addirittura perdersi in posture contemplative o di una sessualità come copula lenta e interrotta solo da riposo e libagioni (come predicavano i grandi libertini alla De Sade), dedicandogli tempo, dedizione e attenzione ai dettagli.
Intendiamoci, intorno al disagio prodotto dal troppo fare senza capocchia si è sviluppata un’intelligente industria della ricarica che ci sforna quotidianamente sessioni di mindfulness, di yoga, di meditazione, di massaggi e agopunture, il tutto purchè poi si sia di nuovo pronti per assicurare alla macchina che macina il nulla il contributo maggiorato derivante dall’essersi almeno un poco riposati.
Così i nostri cuccioli si vedono bersagliati da pubblicità in cui si incensa la loro capacità di correre per sette campi, salire cinque alberi e infilare dodici palloni nel canestro per poi fruire di impagabili barrette al cioccolato o altre misture ricostituenti e energizzanti. La quantità, la velocità, il tempo adeguatamente riempito, così come nelle nostre agende (si chiamano agende mica per niente) in cui uno spazio vuoto può precipitarci in un attacco di panico (cioè la natura (Pan) che si rifà viva per intimarci di smetterla di coglionare la vita), sono diventati gli organizzatori etici del nostro stare al mondo, fin dalla più tenera età. “Tenersi impegnati” è lo slogan infantile, sgobbare come schiavi quello dell’età adulta, anche quando ormai non ci sono più nemmeno padroni che ce lo chiedono: siamo diventati bravissimi, lo facciamo da soli. Toh, qui ho un pomeriggio libero, perché non ci metto un bel corso di Pilates?
A questa mistificazione drammatica della nostra società, della sua cultura induistriale e post-industriale (peggiore perché adesso il lavoro te lo porti comodamente a casa, con la scusa che ci piace…), vorrei, senza tema di affrontare uno dei tabù più coriacei, una pedagogia del dolce far niente, un’educazione all’ozio (eh si, perché bisogna reimpararlo, altrimenti è un attimo finire nel bricolage): otio, non fare (wuwei, dice quel saggio orientale), stare, godere, delibare, sorseggiare la vita, coccolarsi e coccolare, contemplare, ma soprattutto , se proprio si deve usare il corpo a qualche fine, lo si faccia purchè quel fine non produca nulla, se non il puro piacere di farlo, senza ricompensa se non quella intrinseca.
Propongo, nella mia controeducazione, che almeno la metà della nostra vita, per cominciare, sia dedicata al non fare, al non produrre, a non massimizzare il plusvalore del capitale, umano, finanziario o psicologico che dir si voglia.
Chiamatela pure filosofia del non fare un cazzo.