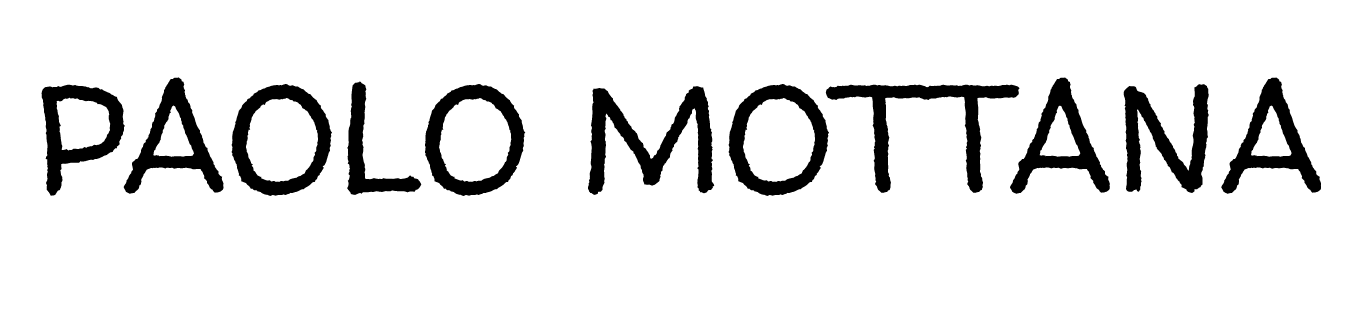Un altro tabù inamovibile nella cultura educativa è indubbiamente quello della violenza, perlomeno da quando l’intimazione pacifista si è installata nel codice del bravo cittadino. L’archetipo del guerriero è tramontato dal dì che fu e l’aggressività sembra essere diventata una malattia. Già l’eccesso di attività viene curato a suon di psicofarmaci.
Come sempre accade tuttavia, laddove si cerca di scacciare un nemico dalla porta, subdolamente rientra dalla finestra. E con Jung dobbiamo riconoscere che se non facciamo i conti con le nostre ombre, queste si ingigantiscono e diventano molto più cupe. Quindi, se prendiamo per buona l’idea che la violenza sia cosa non buona in sé e per sé, non possiamo tuttavia far finta di non vedere che essa continua a circolare, anzi forse circola ancor più di quando essa era onorata nella cultura e nella civiltà e di essa si dava una elaborazione educativa, di solito al maschile ma nondimeno secondo codici, ordini e esercizi.
Oggi la nostra cultura morale l’ha espulsa dal novero delle cose intorno a cui formarsi, con il risultato che essa appare sempre più diffusa sebbene non sempre riconoscibile nelle sue forme tradizionali, fisiche e armate ma molto più spesso mascherata in mille forme forse meno virulente ma certo più pervasive.
Non c’è bisogno di ripescare la ormai vecchia teoria dell’esperienza come schock di Walter Benjamin, contrapposta a quella di una ehrfarung lenta e meditata (cfr.Angelus novus), per riconoscere ovunque la violenza insita in un mondo sovraffollato, anonimo e enormemente accelerato. Per non parlare dell’insidia violenta presente nel rumore, nell’inquinamento atmosferico e in una generale coazione alla prestazione e al successo che porta quasi tutti a sgomitare e a vivere ogni altro come un nemico da abbattere e al meglio come un partner da sfruttare finché serve.
La violenza non è più coltivata come arte, arte della guerra, del combattimento e della difesa epperò appare sempre più ovunque, in forme sfuggenti e martellanti.
I teatri della nostra vita sono violenti, dalle case unifamigliari dove la ristrettezza degli ambienti ma anche quella della disponibilità alla relazione in contesti umani ridotti a pochissime unità conducono ad un continuo duello tra parenti serpenti, alle scuole, campi concentrazionari in cui il dover fare, il controllo, e la sanzione , oltre alla competizione e al produttivismo fungono da detonatori di un’aggressività palpabile talora scatenata per esempio sotto forma di bullismo (discente e insegnante, cfr. Il bullismo insegnante, mottana.it), agli uffici, ai mezzi pubblici, alle fabbriche, alle code automobilistiche, ai ristoranti sovraffollati all’ora di pranzo, alle discoteche, ai pub e via discorrendo, dove, ovunque, ci si deve battere per ottenere un po’ di calma, di silenzio, di spazio vitale.
Molti si sono assuefatti. La tempesta quotidiana che il mondo metropolitano diffuso riversa su chiunque ha fatto i suoi adepti ormai completamente dipendenti dal chiasso, dalla folla, dalla piccola violenza continua come pioggia battente. Ovviamente questa dipendenza cela un deterioramento psichico e nervoso che poi spesso sfocia in comportamenti incontrollati o più spesso in patologie di vario tipo, soprattutto sotto il profilo psicologico.
La violenza è da bandire e la violenza è ovunque. E ogni tanto esplode. Là dove esistono le armi in stragi apparentemente senza motivo, oppure in litigi, in omicidi famigliari di cui spesso sono vittime le donne (sopraffatte ancora da una violenza maschile di cui non riescono a controllare la progressione mortale), in forme di bullismo diffuso, in pratiche sempre più raffinate di perversioni fisiche e immaginarie (sadismo, masochismo, gusto dell’orrore).
La nostra è una civiltà violenta. E lo è da sempre, per quello che ci consta, dal momento che poco sappiamo di una presunta civiltà matrilineare pacifica e figlia del principio del piacere.
Da noi la violenza sta di casa, la pulsione aggressiva è diffusa e inoltre da un po’ di tempo sostanzialmente inelaborata. Perché elaborare l’aggressività non è a mio giudizio principalmente neutralizzarla a forza di buoni sentimenti, esercizi di “intelligenza emotiva” e mindfulness (che è appunto di solito il modo pacifista di affrontare la questione) ma assumerla nella sua specificità, riconoscerla come una pulsione degna di considerazione, di dignità e di una peculiare e non allopatica cura.
L’aggressività si educa con l’aggressività, la violenza cieca con una violenza vigile, la forza con una disciplina della forza e della difesa. Questa violenza esplicita, umana, ha una cultura, una cultura ricca, secolare, che può renderne conto. La violenza si deve poter esprimere, in forme e modi colti, organizzati, come nelle arti marziali, come nelle tecniche di combattimento e di difesa, come nei codici dei grandi sport di offesa e di rispetto (scherma, boxe, lotta ecc.).
Tutti i nostri pargoli e giovanotti, maschi e femmine, dovrebbero poter dedicare una parte del proprio tempo a coltivare le arti dell’aggressione e della difesa, proprio per disinnescarne l’esplosione incontrollata. Un buon guerriero e una buona guerriera non hanno bisogno di esplodere, sanno disciplinare la propria carica aggressiva e eventualmente sfogarla in combattimenti regolati. Far rientrare nella formazione l’arte della guerra non è un peccato mortale contro il tanto osannato pacifismo di superficie che nasconde sia la violenza mascherata e spesso esplosiva sia la violenza esplicita e senza maschera che il nostro mondo infligge a gran parte del mondo più debole fuori dei nostri confini.
La questione è sempre quella del corpo, dei suoi nervi, dei suoi muscoli, di una mente che non può sempre porre riparo all’escalation isterica di una civiltà in guerra con tutto e con sé stessa.
Più difficile ovviamente è lavorare sulla violenza invisibile (cfr. Zizek), sulla violenza mediale, su quella dell’immaginario, su quella del rumore e della folla, della corruzione diffusa e della competizione sociale scatenata. Qui si tratta di una battaglia di lungo corso che deve saper al tempo stesso decongestionare il campo di vita, regolarne le forme di convivenza, attenuare gli effetti di una produttività insensata, imporre codici di relazione e comunicazione all’insegna del rispetto e della cura della quiete. Un cammino lungo che va in direzione ostinata e contraria rispetto a un turbocapitalismo spietato e del tutto acefalo, la cui cura sembra ben lungi dal poter essere anche solo cominciata, almeno fino a che non si cominci a parlare di decrescita, di non fare, del privilegio del tempo liberato, di convivialità e di armonia spazio-temporale, di quella che con un’espressione spesso piuttosto retorica, si dovrebbe chiamare qualità e intensità della vita.
Ma sono questioni distinte. La pulsione aggressiva è parte integrante dell’animale uomo e va coltivata e formata. La violenza di una civiltà all’oscuro di sé stessa, delle sue contraddizioni e delle sue derive distruttive va combattuta e arginata, smussata e contenuta affrontandola sul piano della sua ideologia latente, delle sue pratiche mortifere, del suo fondamentale delirio distruttivo.