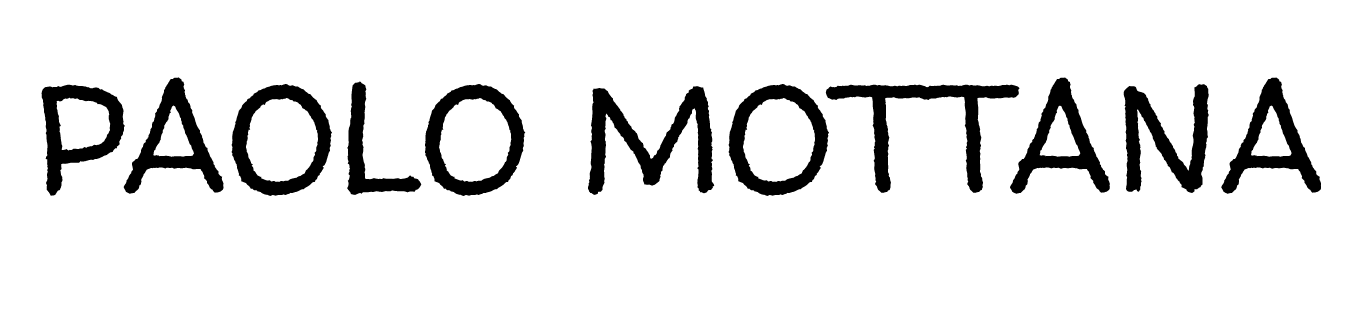Sembra che i nostri giovani siano quelli più indietro –in termini di competenze- per quanto attiene il manometro dell’occupabilità. Dentro di me pensavo, ah però, forse allora sono più intelligenti degli altri. Ma mi zittivo da solo. Pensavo immoralmente, anzi immoralisticamente.
Occupabilità, che parola bizzarra, che sindrome bizzarra quella di cui soffrono coloro che ne sono affetti, l’inoccupabilità. Quella riguarda però di più gli anziani. Con l’invecchiare si diventa inoccupabili. E pensavo. Che liberazione! Poi però mi zittivo di nuovo, perché in verità occorre restare occupabili per tutta la vita. Forse anche dopo. Quindi ragionavo male, poco economicamente, poco eticamente, tenuto conto che quella è l’ultima etica in circolazione.
La connessione più immediata che mi viene, pensando al termine occupato, se non ci fossero gli stetoscopi dell’OCSE o simili, è che occupato si dice di un cesso, pardon, di una ritirata, secondo il vecchio lessico delle ferrovie nord milano. Ma oggi occupato invece è lo status cui tutti aspirano, pur sapendo che, per obbligo morale, non può e non deve, si badi bene, essere permanente. Appunto come per i cessi. E infatti un cesso sempre occupato può risultare d’intralcio al buon andamento dei flussi. Non entro nel merito di quali. Probabilmente non quelli finanziari.
Ma insomma, per dirla in breve, i giovani sono sotto sondaggio continuo per vedere se e quanto sono occupabili.
Certo la parola è bizzarra, e anche ambigua, sotto il profilo linguistico. Occupabili perché possono essere occupati, participio passato del verbo occupare, dove si presume che vi sia un soggetto attivo che li occupa, loro, i giovani, passivi. Un po’ come occupare una casa.
Una volta occupare, occupazione, riguardava soprattutto fenomeni che avevano a che fare con la guerra, nelle forma per esempio di “truppe d’occupazione” oppure con la rivolta, come in “occupare la fabbrica”. Oggi bisogna occupare i giovani. Bisogna insomma entrare in loro con violenza e picchettarne le uscite.
E’, nella sua paradossalità, interessante questa modesta incursione linguistica perché a me questo pare un fenomeno che socio e psico addetti dovrebbero prendere in considerazione. La mia osservazione, del tutto fenomenologica è la seguente: a me pare che i giovani, ma già i bambini, siano occupati in modo selvaggio e continuo. Il problema della nostra civiltà con bambini, ragazzi e giovani, è come occuparli. Lo spettro: il tempo vuoto, non occupato, le mani vuote, non occupate, la testa vuota, non occupata. Si rischia che poi finiscano “sdraiati”, come è stato autorevolmente scritto. Dunque occupiamoli. E così è. Non credo ci sia mai stata una generazione di “minori” così sempre occupati. E non sto a enumerare le infinite attività che si sono create perché anch’essi siano sempre colonizzati dall’intimazione universalmente acclamata e ormai unica fede monoteista rimasta, quella del “fare”.
Sì, perché occupazione, essere occupati, in una delle sue molte accezioni, vuole dire anche e soprattutto questo: essere intenti a fare qualcosa. Dal che, l’espressione, spesso esclamativa, con cui un chiunque, richiamato da altri, può rispondere, per negarsi, “sono occupato!”.
Ma occorre che esca da questo labirinto semantico, altrimenti qualcuno potrà pensare che gioco con le parole (e avrebbe ragione). Ma non si può giocare con le vite (evaporate) della nostra gioventù. Perché, come autorevolmente, da molte fonti si osserva, “occupabilità” è un parametro vitale, appunto. O sei occupabile, o sei destinato all’emarginazione, al degrado, a quella zona dove prolifera la peggior specie di esseri umani, se ancora possano essere così chiamati, oggi viventi, o sopravviventi, gli “inoccupati”.
Gli inoccupati sono creature davvero inquietanti. Niente a che vedere con i “disoccupati”, quelli almeno una volta hanno conosciuto la beatitudine e la cura formativa dell’occupazione. Sono stati bonificati e redenti dall’essere almeno per un po’ stati occupati, da qualcosa o da qualcuno. Ma gli inoccupati, quelli sono devianza pura, sono formazioni fantasmatiche, pura virtualità inagita, vuoti a cercare, zombie.
Si ha paura a circolare per la strada e magari incontrare qualche inoccupato. Creature imprevedibili, fuori dalla gaussiana, infette.
Certo, tra gli inoccupati si comprendono molti quindicenni e sedicenni, quelli sono inoccupati anche un po’ fisiologici, ma, si badi bene, entrano nella parametrazione.
Oggi, come una volta, tenersi occupati, è sempre un grande farmaco, celeberrimo e antico quanto provato farmaco per evitare di cadere nella crapula e nella lussuria, non c’è miglior rimedio al disagio sociale.
Per tenersi occupati, bisogna solo accogliere tutto quello che gli occupanti, i proprietari di un fare da distribuire, chiedono. Avere competenze di base, minime, quello che basta per essere occupabili (cose informatiche, l’inglese, una buona disponibilità a non mettere in discussione nessun tipo di richiesta). L’occupabilità, omettono i nostri organismi internazionali, oggi si misura soprattutto in caratteristiche poco misurabili: non avanzare rivendicazioni di alcun tipo, dismettere ogni dignità, curvare la schiena e mostrarne il fondo affinchè possa essere manipolato e penetrato a piacimento dagli occupanti, e sempre e comunque accettando la conditio sine qua non della cultura dell’occupabilità che suona “mai per sempre”.
Che sembra un peana di gloria e di speranza, ma nel modo dell’evaporazione della vita in cui ahimé sostiamo, significa soltanto la condanna ad essere manovrati come soldatini in un campo di battaglia da un bambino preocemente ubriaco e malevolo, quel bambino avido e feroce che si chiama mercato, che gioca con le vite di tutti ma soprattutto e sempre di più con quelle di chi, ma lui vorrebbe che fossero quelle di tutti, stenta in “occupabilità”.
Orsù, verso un mondo migliore: occupateci, ve ne prego!