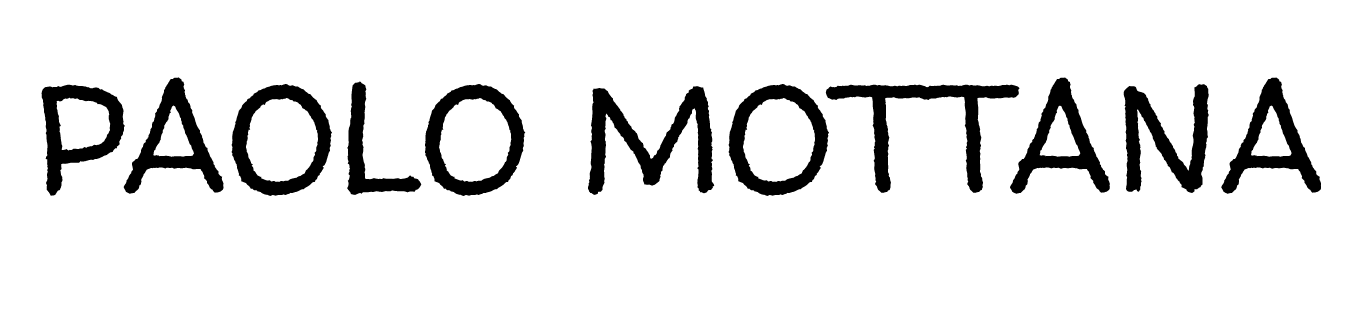Sempre più il non fare mi pare l’unica via di uscita. Non solo come pratica terapeutica antica mirante a una qualche forma di equilibrio psicospirituale. Quanto soprattutto come reazione, come gesto sovversivo nel tempo dell’affaccendamento totale.
Davanti all’agitazione convulsa che muove gli umani in ogni dove nella più radicale confusione e nell’oblio evidente di un qualche straccio di senso che ne orienti l’agitarsi, sento l’impulso al non fare come la risposta necessaria e ineludibile. Opporre il non fare, l’indifferenza alla domanda di agire, lo stare fermi allo sbattere di farfalle impazzite attorno ad una fonte di luce artificiale che non ha nulla di buono da regalare, se non la morte.
Mentre tutto ci chiede di fare qualcosa, sempre, costantemente, non solo gli attori esterni, ben noti, del nostro assoggettamento ad un agire vano, ma anche il tumultuoso esercito interno dei sostenitori del nostro successo professionale, sociale, commerciale. Il più pericoloso, come è noto, quest’ ultimo, camuffato da nobili voci interiori che ci tempestano rimproverandoci di non fare mai abbastanza, di non riuscire mai a “ottenere” abbastanza, di non essere mai abbastanza “riusciti”, “arrivati”, “compiuti”. Di fronte a questo duplice plotone di gerarchi del nulla, arrembanti fuori e scatenati dentro, più tutto il prossimo che ci incalza con la miseria ossessiva delle infinite preoccupazioni quotidiane, di fronte a tutti questi, con impietosa e algida noncuranza, occorre imparare ad opporre la sovrana negligenza del non fare.
Meravigliosa statura di diserzione che finalmente pacifichi il nostro moto inconsulto, che consenta di pensare ma anche di non pensare e di distillare dalla pazienza dell’attesa un desiderio sufficientemente autentico da essere semplicemente diverso da quelli sovraalimentati dalla corrente ad altissimo voltaggio dell’orgia societaria. Un desiderio che ci faccia trasalire per la sua sorprendente aderenza a qualche traccia di sensibilità davvero radicata nella nostra intimità, sempre che sia da qualche parte sopravvissuta. Ebbene qualcosa del genere non può che nascere dall’assoluta interdizione al fare, a quel fare del tutto eterocondotto anche quando lo si ritenga al servizio della nostra affermazione, e che proprio allora semmai riconosciamo nella sua falsità fatalmente perversa.
Nessun bene, nessun successo, nessuna posta in gioco, solo l’ascolto affinato del desiderio ultimo, ormai quasi inattingibile, che giace da qualche parte in un sottosuolo non più frequentato della nostra vita.
Ai superiori gerarchici che ci scrutano attendendosi qualcosa da noi, ai colleghi, che ci sollecitano alla corsa, alla competizione, o che ci sgambettano e ci ostacolano dando però l’esempio di quanto ci si debba mobilitare per apparire vivi e attivi, ai parenti, alle compagne e ai compagni che ci vogliono in azione, di solito un’azione che serva le loro fantasie o i loro bisogni, a tutto l’esercito dei nostri minacciosi portavoce superegoici, a tutti i luogotenenti del corpo al lavoro e sotto il giogo della fatica, occorre contrapporre il serafico ma splendido atto del non fare.
Atto per sottrazione, atto di purificazione, atto di scomparsa, di assentamento. Atto inetto, inadeguato e inatteso. L’atto più difficile per noi dipendenti dall’affaccendamento, ma tanto più soddisfacente quando lentamente si afferma come avvento del meraviglioso, avvento, nel panorama bonificato finalmente dai flussi frenetici del nulla, di uno o due gesti davvero voluti, di una o due azioni quintessenziate carpite al fondo invisibile nel quale erano rimaste confinate e soffocate dal turbinante divenire del nostro autodafé.