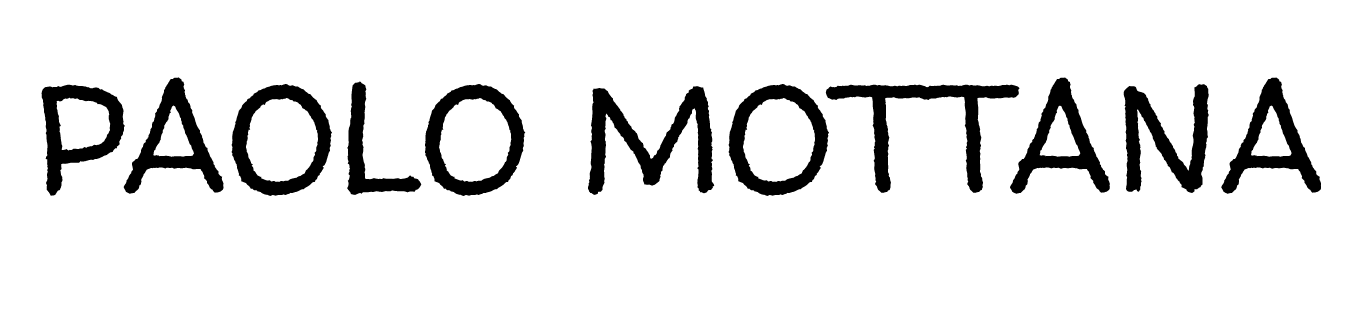Sappiamo ormai con discreta sicurezza che la storia non procede diritta e che comunque dovremo abituarci alla convivenza di tempi asincroni, di discrasie e di stratificazioni complesse nelle manifestazioni future dell’umano, il che peraltro ci consentirà di sperimentare forme di vita multiple e contaminate, sia per radicamento, sia per profilo. Sappiamo altresì che una reversione pura e semplice, come forse qualcuno auspica, non è davvero possibile . Non possiamo resuscitare il fantasma di un io dominatore e legislatore, eroico e progressivo, mosso dalle fantasie faustiane e prometeiche di una definitiva padronanza del mondo. E credo, in buona compagnia, che non valga la pena di dolersene. In compagnia di buoni profeti anche non più recenti, da Kafka a Benjamin, da Deleuze a Hillman, possiamo guardare al nuovo panorama contemporaneo, senza per questo dimenticare che ogni epoca è inevitabilmente segnata dalle sue devianze e dai suoi orrori, con maggiore benevolenza e più fiducioso ascolto immaginativo. Questa postmodernità, come è stata definita con buona approssimazione, è un tempo attraversato da fermenti molteplici e spesso in conflitto, da una pluralità di possibili. Ma è certo un tempo che si è lasciato alle spalle, in larga misura, i miti del passato, e anche le sue certezze. Un tempo dove è molto difficile credere in qualcosa di permanente e duraturo. La morte di Dio è oggi un fatto, non è più solo un’intuizione filosofica ma qualcosa che pervade la vita sociale, qualcosa che i giovani trovano come un dato certificato dal funzionamento sociale stesso, dal trionfo definitivo di un’esistenza appiattita sul pragma, dominata dal puro chronos, governata in profondità dal fattore economico ( che, va ricordato, è anche sempre un fattore sperequativo: al narcisismo dell’occidente risponde la lotta per la sopravvivenza di gran parte del mondo condannato ad una povertà non facilmente superabile), dall’astrazione amorale dello scambio e del profitto, ma anche radicata come mai forse lo è stata nella storia dell’occidente, nell’immanenza e nella terrestrità. Questa compresenza, certo drammatica, apre uno scenario che va interrogato con grande radicalità e anche con un certo disincanto, senza nostalgìe e senza ottimismi ingenui. E anche con l’attenzione fenomenologica che un orizzonte davvero inedito manifesta e su cui dunque invita a calibrare letture pronte a porre con forza in discussione categorie, concetti, modelli davvero ormai inservibili. La fine del padre e di Dio apre scenari forse disturbanti ma anche affascinanti. Oggi non è tempo per istituire nuove sorveglianze e punizioni, per una nuova morale sanzionatoria, per famiglie o scuole normative. Oggi occorre probabilmente un altro atteggiamento. Qualcosa che potrebbe provvisoriamente chiamarsi un “rigore della debolezza”, un’attenzione partecipativa alla fluidità delle forme di vita e alla loro proliferazione molteplice e reticolare, alla loro indole anche eccessiva e trasgressiva. Un’accoglienza, una ricettività, una conversione conoscitiva non giudicante, ricca di immaginazione, mobile, all’insegna di un approccio al reale che sappia avvertire l’avvento di una segnatura epistemologica aperta, contraddittoriale, tensionale. Al posto del vecchio io angosciato e paranoico, si fa strada forse un “io poetico”, minore, immaginale, che accetta di “divenire infante, animale, stella”, come voleva Deleuze. Non c’è più posto per il vecchio soggetto platonico che divide il giorno dalla notte e le idee eterne dalla materia corruttibile, e neanche per quello già più timidamente arroccato nel suo schematismo trascendentale dell’orologiaio di Konigsberg. Men che meno per lo spirito autocomprendente di Hegel, per il suo inveramento storico nella potenza di un Occidente arrogante e imperialista, per quanto consapevole del “negativo” che lo attanaglia. E neppure probabilmente per il ritorno della conversazione felice del giardino epicureo o del duro cammino di scoperta di sé socratico. Forse la nostra modernità ha sviluppato una bizzarra sopravvalutazione dell’individualità umana, un’inflazione, di cui i grandi romanzi di formazione tra la fine dell’800 e l’inizio del 900 hanno portato impressa l’indelebeile traccia. Un individuo ampio, esteso, profondo, allagato dalla molteplicità dei suoi interessi e della sua cultura, attorniato dalla montagna dei suoi ricordi e delle sue imprese, il tutto cumulantesi in profili inconfondibili, insostituibili, irripetibili. Il che ha reso all’individuo stesso tanto ingrato il cedere all’oblìo, alla dissoluzione, al tramontare. Individui talmente affamati di vita da rendere vertiginosa la piramide iridescente delle proprie vite. A quest’immaginario aristocratico e romantico, inevitabilmente sopraffatto da una sensibilità tragica e malinconica, la contemporaneità oppone la sciatteria apparente di una vita senza traccia, fungibile, affondata nella serialità e nella mescolanza. Una vita però forse meglio integrata nella totalità di un mondo più interconnesso, più integrato, per paradosso più simile a quell’universo premoderno in cui l’affermazione di sé non era una destinazione desiderabile, era peccato o manifestazione di colpevole arroganza. Oggi è il tempo del flusso e della rete, delle intensità e di una materia inafferrabile, come ci rivela giorno dopo giorno la ricerca microfisica. L’uomo contemporaneo, ciò che sta venendo alla luce, è non più il fulcro di un organismo ben regolato dalle leggi dell’identità, quel microcosmo capace di riassumere in sé l’intera costellazione deglle analogie cosmiche, né l’identità fondata sulla presenza e sul discorso che ha occupato la scena di tutta la metafisica occidentale. Non vi sono più Sfingi da sfidare all’orizzonte e forse neppure più uno specchio onnipotente cui attribuire tutta l’estraneità del proprio volto. Semmai campi d’insistenza, flussi di energia e di forze che si dissipano e che si attraversano. L’io di oggi è un io diffuso, un io “quantico”, ambiguo nella sua stessa struttura materiale, onda e particella, vivo e morto come il gatto di Schroedinger, partecipe delle molteplici influenze che lo disseminano e che lo trasformano, infinitamente sensibile, un io immaginale, come piace definirlo a James Hillman, notturno e infante, parente del sogno, corpo risonante di una magmatica armonia e disarmonia su cui prova continuamente e insensibilmente ad accordarsi. Più figlio di Proteo e della sua sovrana cangianza che di Apollo e di Teseo, più dionisiaco e orfico che marziale o saturnino, l’io di oggi oscilla tra materia e immateriale, al confine tra il virtuale e il reale, in una zona intermedia che ha i caratteri della flessibilità e dell’iridescenza e che, forse, sta sviluppando una nuova corporeità, più sottile, una carnalità ipersensibile capace , nel tempo, di soggiornare nel caos, nel divenire, nel mutamento certo molto meglio di quel vecchio personaggio donchisciottesco che ambiva a soggiogare la terra. Forse più cinico e strumentale, talvolta, ma anche politeista e non letterale, l’io di oggi e domani sembra bisognoso di sfuggire alle vecchie ipoteche totalizzanti e integratrici, a tutti i maiuscoli dettati dalle metafisiche che lo hanno preceduto. Non più l’io freudiano assediato dall’angoscia, non certo l’io inflazionato di D-io, ma nemmeno l’io dell’od-io e delle grandi passioni, neppure l’io di m-io, l’io del possesso e del domin-io. Un io senza metafisiche, io microfisico e pulviscolare, io desinenza, suffisso mobile e musicale, l’io di obl-io, di desider-io, di add-io.